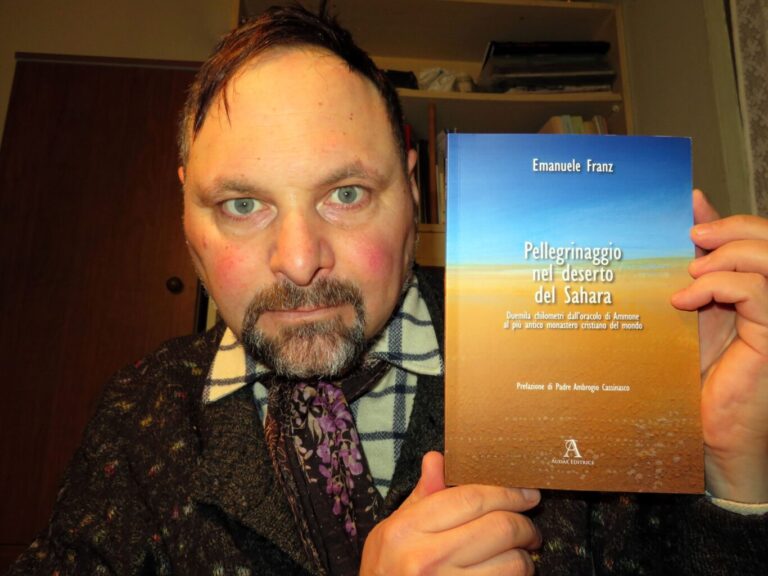Accolti come profughi, i barbari tradirono Roma e la conquistarono
Condividi su:
Il 9 agosto del 378 d.C., nei campi della Tracia, i Goti inflissero a Roma una sconfitta epocale. Solo due anni prima erano stati accolti lungo il Danubio come profughi in fuga dagli Unni; ma in un’epoca in cui la potenza militare dei popoli germanici cresceva e quella di Roma declinava, la loro presenza non significava più sudditanza, bensì un nuovo fattore di forza autonoma e spesso ostile.
Per secoli, Roma aveva offerto ai barbari ciò che nessun’altra potenza poteva dare: sicurezza, stabilità, leggi, infrastrutture, tecniche militari e un sapere organizzativo unico. I confini, seppur militarizzati, erano anche ponti di scambio e di integrazione. Ma questa condivisione, nata da superiorità e fiducia, finì col fornire ai popoli germanici strumenti e conoscenze che, una volta cambiato il rapporto di forza, furono rivolti contro la stessa Roma.
L’inserimento di grandi masse barbariche all’interno dei confini imperiali, e persino nelle file dell’esercito, rese il limes sempre più fragile: agli invasori che arrivavano dalle foreste del nord capitava di trovarsi di fronte soldati che parlavano la loro lingua e condividevano le loro origini. La distinzione tra difensori e potenziali aggressori diventava sottile.
Quando i rapporti di forza si rovesciarono, non furono gli abusi romani a scatenare la ribellione, ma la crescente sicurezza e consapevolezza dei Goti nel poter sfidare apertamente l’autorità imperiale. Ad Adrianopoli, Valente tentò la via della trattativa, ma lo scontro fu inevitabile. La disfatta che ne seguì non fu un incidente isolato, ma il segnale che Roma aveva perso l’iniziativa: il confine danubiano era ormai vulnerabile, e l’Occidente si avviava verso il suo tramonto.