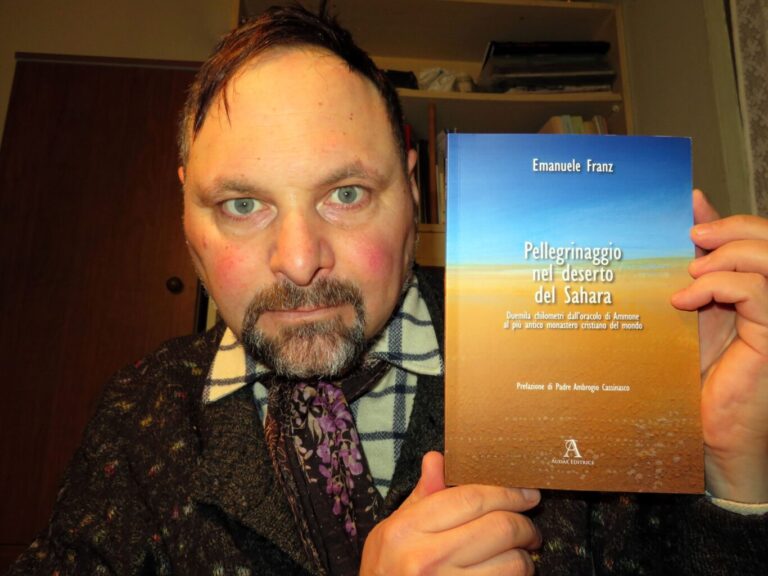I burocrati europei decideranno quali sono i media buoni e quelli cattivi
Condividi su:
L’approvazione dell’European Media Freedom Act (Regolamento UE 2024/1083) ha segnato un momento storico per la regolamentazione dei media nell’Unione Europea. Presentato come un passo avanti per tutelare il pluralismo, l’indipendenza editoriale e la libertà di stampa, il provvedimento ha ricevuto il plauso delle istituzioni europee. Ma non sono mancate le voci critiche, soprattutto da ambienti conservatori e giuridici, che parlano di un esproprio della sovranità nazionale e di una crescente ingerenza della tecnocrazia europea nel sistema mediatico dei singoli Stati.
Un regolamento che centralizza
Il provvedimento ha natura di regolamento europeo, quindi vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. È stato adottato sulla base dell’articolo 114 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, normalmente usato per armonizzare il mercato interno. Per molti esperti, questa scelta giuridica rappresenta un ampliamento anomalo delle competenze dell’UE, dal momento che la regolazione dei media è da sempre una prerogativa statale.
In questa prospettiva, l’EMFA viene letto come una forma di centralizzazione normativa che, pur con obiettivi dichiaratamente democratici, svuota le competenze nazionali in materia di informazione, cultura e comunicazione.
Il controllo tecnocratico: l’ombra di Bruxelles
Tra i punti più controversi vi è l’istituzione dello European Board for Media Services, organismo sovranazionale incaricato di sorvegliare l’applicazione del regolamento. Benché si presenti come indipendente, molti critici sostengono che rappresenti una nuova espressione del potere tecnocratico dell’UE, che interviene su settori delicati come la libertà editoriale e l’autonomia dei media pubblici.
Secondo queste critiche, l’UE rischia di assumere un ruolo paternalistico, definendo dall’alto ciò che è pluralismo, indipendenza o trasparenza, ignorando le diversità culturali e istituzionali tra i vari Paesi.
Un pluralismo omologato?
L’EMFA nasce per tutelare il pluralismo mediatico, ma secondo alcuni osservatori rischia di produrre l’effetto opposto:
-
Impone criteri uniformi su trasparenza della proprietà e governance editoriale;
-
Introduce standard comuni anche a media locali, spesso con risorse limitate;
-
Prevede interventi correttivi da parte delle autorità europee, con poteri diretti.
Questo approccio potrebbe sfociare in un pluralismo omologato, in cui la libertà di essere diversi — anche nelle forme editoriali — viene sacrificata sull’altare dell’uniformità regolatoria.
Le voci critiche in Europa
Le critiche più forti sono arrivate:
-
Dal governo ungherese, unico Stato membro a votare contro l’EMFA in sede di Consiglio dell’UE;
-
Da organizzazioni della stampa, come il Medienverband der freien Presse in Germania, secondo cui il regolamento rappresenta un’intrusione grave nella libertà di stampa;
-
Da analisti giuridici e politici conservatori, che parlano di una tecnocrazia europea fuori controllo, capace di agire senza un mandato democratico diretto.
Anche in sede accademica, diversi studiosi mettono in dubbio la legittimità giuridica del provvedimento, segnalando il rischio che l’UE stia creando un precedente per estendere le proprie competenze a scapito della sovranità dei Parlamenti nazionali.
Il voto italiano
Nonostante queste perplessità, l’Italia ha votato a favore del provvedimento in sede di Consiglio dell’Unione Europea il 26 marzo 2024, approvando formalmente l’accordo raggiunto tra Parlamento e Consiglio. Nessuna opposizione o riserva pubblica è stata sollevata dal governo italiano, che ha dunque confermato l’orientamento favorevole all’approccio europeo in tema di libertà dei media.
Un precedente da monitorare
Il cuore del dibattito non è solo sul contenuto del regolamento, ma sul principio politico che esso introduce: può l’Unione Europea regolamentare direttamente uno dei pilastri della vita democratica – la stampa – senza un esplicito mandato popolare?
Per i critici, l’EMFA rischia di diventare un precedente pericoloso, aprendo la porta a un controllo centralizzato che, pur mascherato da garanzie democratiche, potrebbe degenerare in vigilanza ideologica e ridurre lo spazio di libertà per la stampa non allineata.